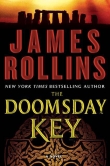Текст книги "L'ordine del sole nero"
Автор книги: James Rollins
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
«Ma non la Campana», disse Painter, riportando la discussione all’argomento originario.
«Non la Campana», convenne Anna. «Mio nonno riuscì a fuggire col cuore del progetto Chronos, nato dalla ricerca sull’energia del punto zero. Il progetto fu ribattezzato Schwarze Sonneda mio nonno, appunto.»
«Sole Nero», tradusse Painter.
« Sehr gut.»
«Ma torniamo alla Campana», riprese Painter. «Che cosa faceva?»
«È la Campana che l’ha fatta ammalare», disse Anna. «L’ha danneggiata al livello dei quanti, dove pillole o altri rimedi non hanno nessun effetto.»
Painter rischiò di scivolare dalle scale. Gli ci volle un momento per digerire l’informazione. Danneggiato al livello dei quanti.Che cosa significava?
Gli ultimi gradini erano bloccati da travi di legno incrociate. Due uomini armati di fucile facevano la guardia. Per quanto stordito, Painter notò la roccia devastata sulla volta dell’ultima curva della tromba delle scale. Davanti a loro si apriva una cripta cavernosa. Painter non riusciva a vedere cosa si nascondeva in fondo a quell’antro, ma sentiva il calore che emanava. Tutte le superfici erano annerite. A terra c’era una fila di sagome avvolte in tela cerata: cadaveri.
Era il sito dell’esplosione che avevano sentito qualche tempo prima. Dalla scena della catastrofe emerse una persona annerita dalla fuliggine, ma ancora riconoscibile. Era Gunther, il bestione che aveva incendiato il monastero. A quanto sembrava, gli inquilini del castello avevano seminato vento e raccolto tempesta…
Gunther si avvicinò allo sbarramento. Anna e Klaus lo raggiunsero. Vedendo i due uomini fianco a fianco, Painter notò una somiglianza tra i due giganti; non tanto nei lineamenti, ma in una certa durezza, in un’aura di estraneità che era difficile da definire.
Gunther salutò Klaus con un cenno del capo. L’altro notò a malapena la sua presenza.
Anna conferì con Gunther, parlando rapidamente in tedesco. Painter riuscì a distinguere una sola parola, identica in tedesco e in inglese: Sabotage.
Quindi non tutto andava per il verso giusto nel Castello di Granito. C’era forse un traditore? Se sì, chi era? E qual era il suo obiettivo? Era un amico o un altro nemico?
Gli occhi di Gunther si posarono su Painter. Le sue labbra si muovevano, ma Painter non riusciva a discernere ciò che diceva. Anna scosse la testa, dissentendo. Gli occhi di Gunther si ridussero a fessure, ma l’uomo fece un cenno di assenso.
Painter sapeva di potersi sentire sollevato. Guardandolo di traverso un’ultima volta, Gunther si voltò e ritornò tra le macerie annerite.
«Ecco quello che volevo mostrarvi.» Anna indicò quella devastazione con un ampio gesto del braccio.
«La Campana», disse Painter.
«È stata distrutta. Un atto di sabotaggio.»
Lisa fissò le macerie. «Ed è stata la Campana a far ammalare Painter.»
«Ed era l’unica possibilità di cura.»
Painter studiò il disastro.
«Avete un duplicato della Campana?» chiese Lisa. «Oppure potete fabbricarne un’altra?»
Anna scosse la testa lentamente. «Uno dei componenti essenziali non può essere riprodotto: lo Xerum 525. Pur essendo passati sessant’anni, non siamo stati in grado di riformularlo.»
«Perciò niente Campana, niente cura», sentenziò Painter.
«Ma forse c’è una possibilità, se ci aiutiamo a vicenda.» Anna gli porse la mano. «Le do la mia parola.»
Non senza una certa rigidità ed esitazione, Painter strinse la mano della donna. Ci doveva essere qualche sotterfugio, qualcosa che Anna non aveva detto. Tutte quelle spiegazioni avevano il solo scopo di fuorviarlo. Perché offrirgli quell’accordo?
D’un tratto capì.
«L’incidente…»
Sentì le dita di Anna contrarsi fra le sue.
«Non è stato un incidente, vero?» Painter ricordò la parola che aveva usato la donna. «È stato un sabotaggio.»
Anna annuì. «Inizialmente abbiamo pensato che si trattasse di un incidente. Altre volte avevamo avuto problemi di sovracorrente, che causavano improvvisi picchi della potenza di uscita della Campana. Niente di straordinario. Scaricando le energie in eccesso si erano verificati alcuni casi di malattia a livello locale e qualche decesso.»
Painter dovette trattenersi dallo scuotere la testa. Niente di straordinario, aveva detto Anna. Quelle malattie e quei decessi erano stati abbastanza straordinarida indurre Ang Gelu a inviare una richiesta d’aiuto dall’altra parte del mondo, facendo arrivare Painter fin lì.
Anna proseguì: «Ma, qualche notte fa, qualcuno ha manomesso le regolazioni durante un test di routine della Campana, aumentando la potenza d’uscita in modo esponenziale»
«E cancellando il monastero e il villaggio.»
«Esatto.»
Painter strinse la presa. Lei era sul punto di ritrarre la mano, ma lui non aveva nessuna intenzione di permetterglielo. Quella donna era ancora elusiva, non aveva rivelato tutto quanto. Ma, come era certo dell’emicrania che lo straziava, Painter era ormai certo anche della verità, che dava un senso a quell’offerta di cooperazione. «Ma non sono stati colpiti soltanto i monaci e gli abitanti del villaggio. Anche tutti voi. Siete tuttimalati come me. Non è la rapida degenerazione neurologica riscontrata al monastero, ma il più graduale deterioramento fisico che sto subendo anch’io.»
Anna lo fissò con gli occhi semichiusi, ponderando quanto rivelare, poi annuì. «Eravamo parzialmente schermati, protetti, in una certa misura. Abbiamo convogliato la parte peggiore delle radiazioni della Campana verso l’alto e poi all’esterno.»
Painter ricordò le luci spettrali avvistate in cima alle montagne. Per risparmiare se stessi, i tedeschi avevano sommerso di radiazioni le vicinanze, compreso il monastero. Ma gli scienziati del castello non erano rimasti del tutto incolumi.
Anna sostenne il suo sguardo, impassibile, decisa. «Ora siamo tutti condannati alla stessa sentenza di morte.»
Painter rifletté sulle sue possibilità di scelta. Non ne aveva. Sebbene nessuna delle parti si fidasse dell’altra, erano tutti sulla stessa barca, perciò potevano pure stringersi un po’. Painter concluse la stretta di mano, suggellando il patto. La Sigma e i nazisti, assieme.
SECONDO
7. IL MAMBA NERO
Riserva di Hluhluwe-Umfolozi,
Zululand, Sudafrica,
ore 05.45
Khamisi Taylor era in piedi di fronte alla scrivania del capo guardacaccia. Rigido e impettito, aspettava che il sovrintendente Gerald Kellog finisse di leggere il suo rapporto preliminare sulla tragedia del giorno precedente.
L’unico suono era il cigolio di un ventilatore a pala che rimestava lentamente l’aria.
Khamisi indossava vestiti presi in prestito: pantaloni troppo lunghi, una camicia troppo stretta. Ma almeno erano asciutti. Dopo aver trascorso tutto il giorno e la notte nello stagno tiepido, immerso fino alle spalle in quella pozza fangosa, con le braccia doloranti per aver tenuto puntato il fucile tutto il tempo, apprezzava quei vestiti caldi e la terra sotto i piedi. Apprezzava anche la luce del giorno. Dalla finestra sul retro dell’ufficio, l’alba dipingeva vagamente il cielo di rosa. Il mondo riemergeva dall’oscurità.
E lui era sopravvissuto.
Era vivo, ma non aveva ancora del tutto accettato quella realtà.
Le urla dell’ ukufagli echeggiavano ancora nella testa.
Gerald Kellog si lisciava distrattamente i folti baffi ramati, mentre continuava a leggere. Il sole del mattino luccicava sulla sua testa pelata, conferendole una lucentezza rosea e untuosa. Finalmente alzò lo sguardo, fissando Khamisi da sopra un paio di occhialini da lettura, due mezze lune sulla punta del naso.
«E questo è il rapporto che lei vorrebbe che io archiviassi, signor Taylor?» Il sovrintendente fece scorrere un dito lungo una riga del foglio giallo. «‘Un grande predatore sconosciuto’: è tutto quello che è in grado di dire sull’animale che ha ucciso e trascinato via la dottoressa Fairfield?»
«Signore, non l’ho potuto guardare bene. Era grosso e aveva il pelo bianco, come ho riferito.»
«Una leonessa, forse», propose Kellog.
«No, signore, non era una leonessa.»
«Come fa a esserne così sicuro? Non ha appena detto che non l’ha visto?»
«Sissignore. Quel che intendevo dire, signore… è che ciò che ho visto non corrispondeva a nessun predatore conosciuto del Lowveld.»
«E allora cos’era?»
Khamisi restò zitto. Non era così sciocco da citare l’ ukufa.Alla luce del giorno, sussurrare storie di mostri avrebbe provocato soltanto derisione.
«Perciò una qualche creatura ha attaccato e trascinato via la dottoressa Fairfield, una bestia che lei non ha visto abbastanza chiaramente per poterla identificare.»
Khamisi annuì lentamente.
«Tuttavia lei è scappato e si è nascosto nello stagno. Secondo lei, che idea dà, questo rapporto, del nostro servizio? Uno dei nostri guardacaccia lascia che una donna di sessant’anni venga uccisa, mentre lui scappa a nascondersi con la coda tra le gambe, senza nemmeno sapere che cosa li ha attaccati.»
«Signore, questa non è una giusta…»
«Giusta?» tuonò il sovrintendente, gridando abbastanza da essere sentito nella stanza accanto, dove per l’emergenza era stato convocato l’intero staff. «È giustoche io debba chiamare i familiari della dottoressa Fairfield per informarli che la loro madre o nonna è stata aggredita e divorata mentre uno dei miei guardacaccia, uno dei miei guardacaccia armati, scappava a nascondersi?»
«Non c’era nulla che io potessi fare.»
«Tranne che salvare quella pellaccia…»
Khamisi sentì la parola omessa di proposito: salvare quella pellaccia nera.
Gerald Kellog non aveva assunto Khamisi con entusiasmo. La famiglia del sovrintendente era legata all’ex governo afrikander e lui aveva fatto carriera grazie a quelle conoscenze e a quei legami. Apparteneva ancora al vecchio country club Oldavi, esclusivamente bianco, il quale, anche dopo la fine dell’apartheid, era un importante centro di potere. Sebbene fossero state approvate nuove leggi, abbattute barriere e fossero stati costituiti sindacati, gli affari erano ancora affari in Sudafrica. I De Beers erano ancora proprietari delle miniere di diamanti e i Waalenberg possedevano quasi tutto il resto.
I cambiamenti sarebbero stati lenti.
Il posto di lavoro di Khamisi era un piccolo passo, una porta che lui voleva tenere aperta per la generazione successiva. Perciò mantenne la calma. «Sono sicuro che quando gli investigatori esamineranno il sito giustificheranno la mia linea di condotta.»
«Ah, davvero, signor Taylor? Ho mandato una dozzina di uomini, un’ora dopo che l’elicottero di soccorso l’aveva trovata a sguazzare nel fango, dopo la mezzanotte. Hanno fatto rapporto quindici minuti fa. Hanno trovato la carcassa del rinoceronte, ridotta quasi a uno scheletro da sciacalli e iene. Neanche una traccia del cucciolo che lei ha citato. E, soprattutto, neanche una traccia della dottoressa Fairfield.»
Khamisi scosse la testa, cercando una via d’uscita da quelle accuse. Ripensò alla lunga veglia nello stagno. Il giorno sembrava non finire mai, ma la notte era stata anche peggio. Dopo il tramonto, Khamisi si era aspettato di essere attaccato. Invece aveva sentito l’uggiolio delle iene e i latrati degli sciacalli che si riversavano nella valle, accompagnati da ringhi e guaiti dei vari spazzini che si contendevano i resti.
La presenza dei saprofagi aveva quasi indotto Khamisi a pensare di raggiungere la Jeep senza troppi rischi. Se erano ritornati le solite iene e i soliti sciacalli, forse l’ ukufase n’era andato.
Ma poi Khamisi non si era mosso.
Aveva ancora fresca nella memoria l’imboscata che aveva colto di sorpresa la dottoressa Fairfield.
«Sicuramente c’erano altre tracce», disse al sovrintendente.
«C’erano.»
Khamisi s’illuminò. Se c’era una prova…
«Erano tracce di leonesse», proseguì Kellog. «Due femmine adulte, proprio come dicevo prima.»
«Leonesse?»
«Sì. Credo che abbiamo qualche fotografia di quelle strane creature, da qualche parte. Forse è meglio che se le studi, così in futuro le saprà identificare. Con tutto il tempo libero che avrà…»
«Signore?»
«Lei è sospeso.»
Khamisi non poté nascondere lo stupore. Sapeva che se fosse capitato a un altro guardacaccia – a un qualsiasi guardacaccia bianco —ci sarebbe stata maggiore indulgenza, maggiore fiducia. Ma non per uno che aveva la pelle della tribù. Sapeva che era inutile discutere, avrebbe soltanto peggiorato le cose.
«Senza retribuzione, signor Taylor. Finché non sarà completata un’indagine approfondita.»
Un’indagine approfondita. Khamisi sapeva come sarebbe andata a finire.
«E la polizia locale mi ha chiesto di riferirle che non deve lasciare la zona. Bisogna chiarire anche le eventuali responsabilità penali.»
Khamisi chiuse gli occhi. Anche se il sole stava sorgendo, l’incubo non voleva saperne di terminare.
Dieci minuti dopo, Gerald Kellog era ancora seduto alla sua scrivania, da solo. Si passò una mano sudata sulla testa, come se lustrasse una mela. Le labbra, serrate in un’espressione arcigna, si rifiutavano di distendersi. La notte era stata interminabile, aveva dovuto spegnere un incendio dopo l’altro; e c’erano ancora mille dettagli da gestire: parlare coi media, occuparsi della famiglia della biologa, compresa la compagna della dottoressa Fairfield.
Kellog scosse la testa pensando a quella questione. La dottoressa Paula Kane sarebbe stata l’osso più duro della giornata seguente. Sapeva che il rapporto tra le due donne non si limitava al lavoro di ricerca. Era stata Paula Kane a insistere per fare uscire l’elicottero, quella notte, quando la dottoressa Fairfield non era tornata dall’escursione.
Svegliato nel mezzo della notte, Kellog l’aveva invitata a mantenere la calma. A tirarlo giù dal letto fu l’informazione sul luogoin cui la dottoressa Fairfield si era diretta, assieme a uno dei suoi guardacaccia: il confine nordoccidentale del parco, non lontano dalla riserva privata dei Waalenberg.
Una ricerca in quei paraggi richiedeva la sua immediata supervisione.
Era stata una notte frenetica, che aveva richiesto interventi rapidi e coordinamento, ma era quasi finita.
C’era soltanto un ultimo dettaglio di cui occuparsi.
Kellog sollevò la cornetta e compose il numero privato. Aspettò di prendere la linea, picchiettando una penna su un taccuino.
«Riferisca», fu la risposta laconica a collegamento avvenuto.
«Ho appena concluso il colloquio.»
«E?»
«Non ha visto nulla… nulla di chiaro.»
«Che cosa significa?»
«Sostiene di avere intravisto qualcosa. Nulla che potesse identificare.»
Seguì un lungo silenzio.
Kellog diventò nervoso. «Il suo rapporto sarà modificato. Si è trattato di leonesse, sarà questa la conclusione. Ne abbatteremo qualcuna, tanto per andare sul sicuro, e la questione sarà chiusa tra un giorno o due. Nel frattempo l’ho sospeso.»
«Molto bene. Lei sa che cosa deve fare.»
Kellog protestò. «È stato sospeso, non oserà agitare le acque. L’ho spaventato per bene. Non penso…»
«Esatto, non pensi. Ha ricevuto i suoi ordini. Lo faccia sembrare un incidente.»
La linea fu interrotta.
La stanza era un forno, a dispetto del ronzio dell’aria condizionata e delle pigre rotazioni del ventilatore. Niente poteva davvero contrastare il calore cocente della savana, con l’avanzare della giornata.
Ma non era per la temperatura che la fronte di Kellog era imperlata di sudore.
Ha ricevuto i suoi ordini.
E sapeva bene che non era il caso di disobbedire.
Guardò il taccuino, sulla scrivania. Parlando al telefono aveva fatto qualche scarabocchio distrattamente, segno di quanto lo mettesse a disagio l’uomo all’altro capo della linea.

Kellog si affrettò a cancellarlo con la penna, strappò il foglio e lo fece a brandelli. Nessuna prova. Mai. Era la regola. E lui aveva i suoi ordini.
Lo faccia sembrare un incidente.
In volo sulla Germania,
ore 04.50
«Atterreremo tra un’ora», disse Monk. «Forse dovresti provare a fare un altro sonnellino.»
Gray si stiracchiò. Il cupo ronzio del jet Challenger 600 l’aveva cullato sino a farlo addormentare, ma la sua mente ritornava agli eventi della giornata, cercando di ricomporre il puzzle. Aveva la Bibbia di Darwin aperta davanti a sé. «Come sta Fiona?»
Con un cenno del capo, Monk indicò il divano in fondo. Fiona era distesa, con una coperta addosso. «È crollata, finalmente. C’è voluto qualche analgesico per metterla fuori gioco. Quella ragazzina non chiude mai la bocca.»
Non aveva smesso di parlare da quando erano arrivati all’aeroporto di Copenhagen. Gray aveva avvertito Monk per telefono e lui aveva organizzato un’auto privata per portarli rapidamente e senza pericolo all’aeroplano che faceva rifornimento. Logan aveva risolto tutte le questioni diplomatiche e di visti.
Tuttavia Gray aveva ripreso a respirare regolarmente soltanto quando il Challenger si era staccato dal suolo e aveva preso quota.
«La sua ferita?»
Monk scrollò le spalle e sprofondò nella poltrona di fronte. «Un graffio. Okay, un graffio brutto e profondo. Le farà un male cane nei prossimi giorni. Ma, con un po’ di antisettico, un cicatrizzante liquido e un buon bendaggio, sarà in gran forma entro un paio di giorni. Pronta per rapinare un altro po’ di gente.»
Monk si tastò la giacca, assicurandosi di avere ancora il portafogli.
«L’ha rubato soltanto per darti il buongiorno», disse Gray, celando un sorriso stanco. Grette Neal gliel’aveva spiegato il giorno prima. Dio, era passato soltanto un giorno?
Mentre Monk si occupava di Fiona, Gray aveva fatto rapporto a Logan. Il direttore ad interim non era felice di sentire le sue avventure dopo l’asta… un’asta alla quale gli era stato vietato di partecipare. Ma il danno era fatto. Per fortuna aveva ancora la chiave USB con le foto di tutti i partecipanti, compresa la coppia dai capelli biondo platino. Aveva inviato tutto quanto a Logan, faxandogli anche alcune pagine della Bibbia e dei suoi appunti. Gli aveva mandato inoltre il disegno del tatuaggio a forma di quadrifoglio che aveva visto sulla mano degli aggressori, di quella specie di squadriglia di sconosciuti assassini biondi.
Logan e Kat si sarebbero dati da fare per scoprire chi ci fosse dietro. Logan aveva già avviato indagini presso le autorità di Copenhagen. Non erano stati riferiti decessi al lunapark. A quanto sembrava, il corpo dell’assassino che avevano agganciato con l’ala dell’anatroccolo era scomparso. Perciò la loro fuga da Tivoli non aveva lasciato strascichi fra la gente strattonata, a parte qualche contusione e qualche graffio. Nessun ferito grave, tranne il carro della parata.
Gray guardò Monk che controllava le tasche dei jeans. «C’è ancora, l’anello?»
«Non c’era bisogno di rubare anche quello.»
Gray doveva riconoscere la destrezza di Fiona. «Allora, vuoi dirmi qualcosa di quel cofanetto per anelli?»
«Ti volevo fare una sorpresa…»
«Monk, non sapevo che mi volessi così bene.»
«Ma piantala! Intendevo che te lo volevo dire io, senza che la signorina Copperfield decidesse di tirarlo fuori dal cilindro.»
Gray si appoggiò allo schienale, guardando in faccia Monk, con le braccia conserte. «Perciò hai intenzione di chiederglielo. Non so… La signora KatKokkalis. Non acconsentirà mai.»
«Non credo neanche io. Questo dannato coso l’ho comprato due mesi fa. Non ho mai trovato il momento buono per chiederglielo.»
«Vuoi dire che non hai mai trovato il coraggio.»
«Be’, forse anche quello.»
Gray si sporse in avanti e diede un buffetto sul ginocchio dell’amico. «Ti ama, Monk. Smettila di preoccuparti.»
Lui sorrise come un ragazzino. Non gli donava molto, ma Gray riconobbe dallo sguardo di Monk quanto erano profondi i suoi sentimenti… accompagnati da una punta di paura. Monk si sfregò il punto in cui la protesi della mano si congiungeva col moncherino del polso. Nonostante la spavalderia che ostentava, era stato scosso profondamente dalla mutilazione dell’anno precedente. L’attenzione di Kat aveva contribuito alla sua guarigione molto più degli sforzi dei medici. Ma gli restava una vena profonda di insicurezza.
Monk aprì il cofanetto di velluto e guardò l’anello di fidanzamento da tre carati. «Forse avrei dovuto comprare un diamante più grande, soprattutto adesso.»
«Che vuoi dire?»
Monk lo guardò. Aveva una nuova espressione sul viso: una traballante speranza era il modo migliore di descriverla. «Kat è incinta.»
Gray si drizzò sul sedile, sorpreso. «Cosa? Come?»
«Penso che tu sappia come», rispose Monk.
«Cristo! Congratulazioni», farfugliò, mentre si riprendeva gradualmente. L’ultima frase suonò più come una domanda: «Voglio dire… lo tenete, il bambino».
Monk inarcò un sopracciglio.
«Naturalmente», disse Gray, scuotendo la testa per la sua stupidità.
«È ancora presto», replicò Monk. «Kat vuole che non lo sappia nessuno, ma ha detto che a te potevo dirlo.»
Gray annuì, dandosi tempo per assimilare la notizia. Cercò di immaginarsi Monk padre e fu sorpreso di quanto fosse facile. «Mio Dio, è fantastico.»
Monk chiuse il cofanetto. «E tu?»
Gray lo guardò perplesso. «Io cosa?»
«Tu e Sara. Che ha detto quando le hai raccontato delle tue avventure a Tivoli?»
La fronte di Gray si corrugò.
Monk sgranò gli occhi. «Gray…»
«Cosa?»
«Non l’hai ancora chiamata, vero?»
«Non pensavo…»
«È nei carabinieri. Perciò sai benissimo che verrebbe a sapere di qualsiasi potenziale attentato terroristico a Copenhagen. Soprattutto se c’era un pazzoide che urlava ‘bomba’ in un parco affollato e se ne andava in giro in un carro da parata. Non potrà fare a meno di pensare che ci sia in mezzo proprio tu.»
Monk aveva ragione. Avrebbe dovuto chiamarla subito.
«Grayson Pierce, che cosa devo fare con te?» Monk scosse la testa tristemente. «Quando lascerai in pace quella ragazza?»
«Di che stai parlando?»
«Sono felice che tu e Sara vi siate trovati, ma dove avete intenzione di andare?»
Gray s’innervosì. «Non che siano affari tuoi, ma era quello che avevamo intenzione di discutere, prima che scoppiasse l’inferno.»
«L’hai scampata.»
«Sai una cosa? Il fatto di avere in tasca da due mesi un anello di fidanzamento non ti fa diventare improvvisamente un esperto di relazioni.»
Monk alzò le mani. «Va bene, come non detto… Stavo soltanto dicendo…»
Gray non aveva intenzione di fargliela passare liscia. «Che cosa?»
«Tu non vuoi davvero una relazione.»
Quell’attacco frontale lo lasciò di stucco. «Di che cosa stai parlando? Sara e io ci siamo fatti in quattro per far funzionare questa cosa. Io amo Sara, lo sai bene.»
«Lo so. Non ho mai detto il contrario. È solo che tu non vuoi avere una verarelazione con lei.» Monk contò fino a tre con le dita: «Significa moglie, mutuoe figli».
Gray si limitò a scuotere la testa.
«Quello che stai facendo con Sara è goderti un primo appuntamento prolungato.»
Gray cercò di ribattere in qualche modo, ma Monk era andato troppo vicino al bersaglio. Gli venne in mente la goffaggine che doveva superare ogni volta che lui e Sara si rivedevano, quella barriera da sormontare prima di poter ristabilire un’intimità più profonda. Come a un primo appuntamento.
«Da quanto tempo ti conosco?» chiese Monk.
Gray cancellò la domanda con la mano.
«E in tutto questo tempo quante storie serie hai avuto?» Monk formò un grande zero con la mano. «E guarda chi vai a pescare per la tua prima relazione seria.»
«Sara è meravigliosa.»
«È vero. E trovo fantastico che tu ti stia finalmente aprendo. Ma, ragazzi, quando si dice mettere in piedi barriere invalicabili!»
«Quali barriere?»
«Che ne dici dell’oceano Atlantico, tanto per cominciare? Quello che sta tra te e una vera relazione.» Monk agitò tre dita davanti a lui.
Moglie, mutuo, figli.
«Non sei pronto», proseguì Monk. «Avresti dovuto vedere la tua faccia quando ho detto che Kat è incinta. Ti è venuta la cacarella, anche se il bambino è mio.»
Gray aveva il cuore in gola. Si accorse di respirare affannosamente. Come se si fosse preso un pugno nello stomaco.
Monk sospirò. «Hai qualche problemino, amico mio. Forse hai qualcosa da risolvere coi tuoi vecchi. Non so.»
Gray fu salvato dal suono dell’interfono.
«Siamo a circa trenta minuti dalla destinazione», riferì il pilota. «Tra poco cominceremo la discesa.»
Gray guardò fuori dal finestrino. Il sole stava sorgendo. «Provo a fare un altro pisolino. Finché non atterriamo.»
«Buona idea.»
Gray si voltò verso Monk. Aprì la bocca per rispondere in qualche modo alle sue parole, ma alla fine si limitò a dire la verità. «Io amo davvero Sara.»
Monk reclinò lo schienale della poltrona e si mise su un fianco con un grugnito. «Lo so. Per questo è così difficile.»
Riserva di Hluhluwe-Umfolozi,
ore 05.45
Khamisi Taylor sorseggiava il tè nel piccolo salotto. Per quanto fosse un’ottima infusione, addolcita col miele, non ne sentì neanche il sapore.
«E non c’è nessuna possibilità che Marcia sia ancora viva?» chiese Paula Kane.
Khamisi scosse la testa. Non cercava di eludere quella realtà. Non era il motivo per cui era andato lì, dopo la lavata di capo da parte del sovrintendente. Avrebbe voluto ritirarsi nella sua casetta ai margini della riserva, dove c’era una schiera di costruzioni basse, affittate ai guardacaccia. Si chiedeva per quanto ancora sarebbe potuto rimanere ad abitare lì, se la sospensione si trasformava in licenziamento.
Ma non era tornato direttamente a casa. Aveva attraversato in auto metà del parco, fino a un altro complesso di alloggi temporanei, una piccola enclave in cui risiedevano i ricercatori.
Khamisi era stato molte volte in quella casa coloniale bianca a due piani, coi suoi giganteschi e ombrosi alberi di acacia, col minuscolo giardino e col piccolo cortile in cui gironzolava qualche pollo. Sembrava che le due inquiline non rimanessero mai senza sovvenzioni. L’ultima volta che Khamisi ci era andato, era stato per festeggiare il decimo anniversario della permanenza delle due donne al parco. Ormai erano diventate un’istituzione, nella comunità scientifica di Hluhluwe-Umfolozi, un po’ come i cinque grandi animali da trofeo.
Ma ora ne rimaneva soltanto una.
La dottoressa Paula Kane era seduta su un divanetto, di fronte a Khamisi e al tavolino che li divideva. Aveva le lacrime agli occhi, ma le guance ancora asciutte. «Va bene», disse, mentre il suo sguardo vagava verso una parete piena di foto, panorama di una vita felice. Khamisi sapeva che le due donne erano assieme da quando avevano frequentato l’università di Oxford, molti anni prima. «Ormai non ci speravo più.»
Era una donna minuta, coi capelli brizzolati, tagliati pari all’altezza delle spalle. Sebbene fosse prossima ai sessanta, mostrava dieci anni di meno. Aveva sempre conservato una bellezza adamantina e una grande sicurezza, che non si lasciava mimetizzare neanche dal trucco. Quella mattina, però, sembrava appassita, sembrava l’ombra di se stessa, come se avesse perso qualcosa di vitale. Probabilmente aveva dormito vestita, con quei pantaloni kaki e quella camicetta bianca.
Khamisi non aveva parole per alleviare il dolore scolpito in ogni parte del corpo della donna, soltanto la sua partecipazione. «Mi dispiace.»
Paula lo guardò. «So che hai fatto tutto il possibile. Ho sentito le voci che cominciano a girare. Una donna bianca muore, ma il nero sopravvive. A certi elementi di qui non andrà giù.»
Khamisi sapeva che la donna si riferiva al capo guardacaccia. Paula e Marcia si erano scontrate molte volte con quell’uomo. Lei conosceva i legami e le affiliazioni del sovrintendente come tutti gli altri. Forse l’apartheid era stato eliminato nelle città e nelle township, ma nella savana il mito del Grande Cacciatore Bianco continuava a regnare supremo.
«Tu non sei responsabile della morte di Marcia», proseguì Paula, leggendogli qualcosa in viso.
Lui distolse lo sguardo. Apprezzava la sua comprensione, ma le accuse del sovrintendente avevano rintuzzato un senso di colpa già latente. Razionalmente sapeva di aver fatto tutto il possibile per proteggere la dottoressa Fairfield. Ma lui ne era uscito vivo, e lei no. Quelli erano i fatti.
Khamisi si alzò. Non voleva disturbare oltre. Era andato lì per rendere i suoi omaggi e per dire di persona alla dottoressa Kane che cosa era accaduto. «Ora devo andare.»
Paula si alzò e lo accompagnò alla porta a zanzariera. Lo fermò con una mano, prima che uscisse. «Secondo te, che cosa è stato?»
Lui si voltò verso di lei.
«Che cosa l’ha uccisa?» insistette Paula.
Khamisi guardò fuori: c’era troppa luce per parlare di mostri. In più, gli era stato vietato di riferire particolari della faccenda. C’era in ballo il suo lavoro.
Guardò Paula e le disse la verità. «Non è stata una leonessa.»
«E allora che cosa?»
«Lo scoprirò.»
Spinse la porta e scese i gradini. Il suo piccolo pick-up arrugginito era parcheggiato sotto il sole. Lo raggiunse, salì nell’abitacolo rovente e prese la strada di casa.
Per la centesima volta, rivisse il terrore della giornata precedente. Sentiva a fatica il rombo del motore, sovrastato dall’eco delle urla dell’ ukufanella sua testa. Non era una leonessa. Non ci avrebbe mai creduto.
Raggiunse gli alloggi destinati allo staff del parco, una schiera di costruzioni improvvisate su palafitte senza aria condizionata. Sollevando una nuvola di polvere rossa, parcheggiò di fronte al cancello di casa sua.
Esausto, aveva intenzione di riposare per qualche ora. Poi sarebbe andato in cerca della verità.
Sapeva già dovecominciare le indagini.
Ma l’avrebbe fatto più tardi.
Mentre si avvicinava alla recinzione del cortile davanti alla casa, notò che il cancello era socchiuso. Si assicurava sempre di chiuderlo col paletto, quando usciva, ogni mattina. D’altra parte, dopo l’annuncio della loro scomparsa, la notte precedente, era possibile che qualcuno fosse andato a cercarlo a casa.
Ma i sensi di Khamisi erano ancora in allerta, fin dal momento in cui aveva sentito quel primo urlo nella giungla. Dubitava persino che quella condizione potesse mai cambiare.
S’infilò nel cortile. Notò che la porta d’ingresso sembrava chiusa e vide la posta che sporgeva dalla cassetta delle lettere: non era stata toccata. Salì i gradini, uno alla volta.
Avrebbe voluto avere un pugnale o una pistola.
Sentì uno scricchiolio. Non proveniva dai gradini sotto i suoi piedi, ma dalle tavole del pavimento, dentro la casa.
I suoi sensi gli dicevano di fuggire.
No. Stavolta no.
Raggiunse il portico, si mise a lato della porta e controllò il catenaccio.
Non era chiuso a chiave.
Lo sganciò e spinse la porta. Sentì scricchiolare il pavimento un’altra volta, in fondo alla casa.